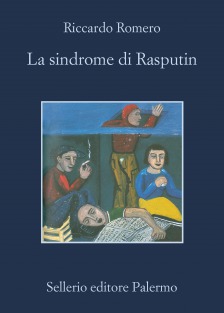Constantino Bértolo
Organizzare la non lettura
«Si uno lo piensa bien, el trabajo de una editorial es organizar la no lectura. Imaginate que a una editorial muy discreta llegan unos 500 manuscritos como mínimo. ¿Vas a leer los 500 manuscritos? ¿Qué haces con esto? Seamos honrados, vamos a hacer una criba. Ahora bien, ¿a qué se llama leer en una editorial? En gran parte a no leer. Abro una novela y la dedicatoria dice: “A mi mamá que siempre…”, entonces yo no sigo leyendo esa novela. Paso la primera página y leo: “Era de noche y sin embargo llovía…” Bueno, ¿para qué voy a seguir leyendo? Parte del trabajo de un editor es eliminar lectura. En una criba que haces a partir del conocimiento y sabiduría de tu trabajo como editor de esos 500 quedan 100, siendo generosos, pero 60 que hay que leer. Si tienes una editorial con infraestructura, se los das a un grupo de lectores que has elegido. Ellos te hacen unos informes y tu propia práctica te hace darte cuenta de que hay 40 que no vas a leer. Al final, lo que lees es 20. ¿Pero qué es lo que has hecho realmente? No leer 480. ¿Se entiende en qué consiste el trabajo paradójico del editor?».
˜
«Se uno ci pensa bene, il lavoro di una casa editrice è organizzare la non lettura. Considera che a una casa editrice medio-piccola arrivi un minimo di 500 manoscritti. Li leggi tutti e 500? Che ne fai di tutta quella roba? Siamo onesti, bisogna fare una selezione. Quindi, che cosa chiamiamo leggere in una casa editrice? In gran parte, il non leggere. Apro un romanzo e la dedica dice: “Alla mia mamma che mi ha sempre…”, e allora non vado avanti a leggere quel romanzo. Giro la prima pagina e leggo: “Era notte e tuttavia pioveva…”, be’, perchè continuare? Parte del lavoro di un editore è eliminare la lettura. È una selezione che fai a partire dalla conoscenza e dall’esperienza del tuo lavoro di editore. Di quei 500 ne rimangono 100, a voler esser generosi, ma 60 sono quelli da leggere. Se hai una casa editrice con dei collaboratori, lo dai a un gruppo di lettori che hai scelto. Loro ti fanno delle schede e la pratica che hai del mestiere ti permette di capire che ce ne sono 40 che non leggerai. Alla fine, ne leggi 20. Ma che cos’hai fatto in realtà? Non ne hai letti 480. Si capisce adesso in che cosa consiste il lavoro paradossale dell’editore?”
Silvina Friera, «No concibo la literatura como un campo autónomo», intervista a Constantino Bértolo in «Radar», supplemento a «Página/12» Buenos Aires, 14 ottobre 2015.
Filed under: editoria | Leave a Comment
Tag:Constantino Bértolo, editoria, leggere, lettura
Jorge Luis Borges 3
I dizionari
«De acuerdo a los diccionarios, los idiomas son repertorios de sinónimos, pero no lo son. Los diccionarios bilingües, por otra parte, hacen creer que cada palabra de un idioma puede ser reemplazada por otra de otro idioma. El error consiste en que no se tiene en cuenta que cada idioma es un modo de sentir el universo o de percibir el universo».
«Secondo i dizionari, le lingue sono repertori di sinonimi, ma non lo sono. I dizionari bilingui, poi, fanno credere che ogni parola di una lingua può essere sostituita da un′altra di un’altra lingua. L′errore sta nel non tener conto che ogni lingua è un modo di sentire l′universo o di percepire l′universo».
Jorge Luis Borges, El oficio de traducir, in «Sur», 338-339, gennaio-dicembre 1976; raccolto poi nel volume Borges en Sur (1931-1980), e in Miscelánea, Penguin Random House, Barcelona, 2011, p. 689. La traduzione è mia.
Filed under: letteratura, traduzione | Leave a Comment
Tag:Borges, dizionari, traducción, tradurre
Beccaria e Pascoli e Wiener
Il verde e il viola della lingua
«La lingua è sentita a un certo punto (basterebbe citare confessioni espilcite, da Baudelaire a Musil a Pascoli) come il risultato di processi statici: «grigia», dice Pascoli, scolorita, come se i parlanti fossero tutti daltonici. Il suono può ridestarla. […]
Uno scrittore moderno, Oswald Wiener, nel suo Verbesserung von Mitteleuropa (1969) ci fa leggere a un certo punto:
Il mio colore preferito è il verde, il suo il viola; ci piace lo stesso colore perché, se potessimo confrontare le nostre sensazioni, il mio verde sarebbe il suo viola. Ma per termine di confronto abbiamo solo la lingua.
Pascoli, credo, avrebbe sottoscritto.»
[1982]
Gianluigi Beccaria, Le forme della lontananza, Garzanti, Milano, 1989; 2001, p. 179.
Filed under: letteratura, scrivere | Leave a Comment
Tag:Charles Baudelaire, Gianluigi Beccaria, Giovanni Pascoli, suono, Walter Wiener
Carlo Ginzburg e Proust
Una frase quasi trasparente
Nel proporre il «paradigma indiziario» mi ero richiamato a Leo Spitzer, oltre ad Aby Warburg, a Marc Bloch … e ad Adorno… Dopo aver finito la Recherche lessi il saggio di Spitzer Sullo stile di Proust. Ma il senso vero di quelle pagine, che certo segnarono un momento di svolta nella traiettoria ermeneutica di Spitzer, mi è diventato chiaro solo recentemente. Esse si aprono dichiarando il profondo debito intellettuale contratto nei confronti di un altro saggio su Proust, apparso tre anni prima: quello di Ernst Robert Curtius, pubblicato nel 1925. Scriveva Spitzer: «Il metodo con il quale Curtius giunge a scoprire lo “spirito” Proust nella sua lingua, l’ha insegnato Proust stesso, ed è il medesimo che io vado proponendo da anni. Il critico comincia a leggere, ed è dapprima sorpreso da quello stile così singolare, fino a quando non trova una “frase quasi trasparente”, che gli fa presentire il carattere dello scrittore: proseguendo la lettura incontra una seconda e una terza frase dello stesso genere, e finisce così per intuire la “legge” che permette di comprendere “lo spirito formale di un autore”. … a mio parere, questo metodo, che in fondo vuol essere soprattutto un invito a leggere e rileggere i testi studiati, non vale solamente per Proust, ma per ogni autore, di cui si voglia veramente comprendere la lingua».
…
Ma il Curtius lettore di Proust non faceva che riecheggiare, con grande intelligenza, Proust stesso: in particolare, la prefazione con cui si apre La Bibbia di Amiens di Ruskin da lui tradotta. Ne cito due passi: «Ora, parlando una volta con una persona, si possono notare in lei dei gesti singolari; ma è soltanto per il loro ripetersi in circostanze diverse che si possono riconoscere come caratteristici ed essenziali. Per uno scrittore, per un musicista, o per un pittore, questa variazione delle circostanze permette di notare, come in una specie di esperimento, i segni immutabili del carattere e la varietà delle opere. (…) In fondo, aiutare il lettore a rilevare questi segni singolari, mettere sotto i suoi occhi i modi analoghi che gli permettano di considerarli segni essenziali del genio di uno scrittore, dovrebbe essere il compito più importante di ogni critico».
Carlo Ginzburg, Che cosa gli storici possono imparare da un testo sui generis come la «Recherche», in «L’indice dei libri del mese», n. 6, XXX, 14 giugno 2013.
Filed under: letteratura | Leave a Comment
Tag:Carlo Ginzburg, Ernst Robert Curtius, leggere, Leo Spitzer, letteratura, Marcel Proust, Ruskin, stile, stilistica
Antonietta Pastore & Murakami
E invece ha ragione lui
A volte succede che Murakami mi irriti o mi stanchi. Non perché i suoi testi siano particolarmente difficili, al contrario: scrive in una lingua piuttosto semplice che riproduce quella parlata, e non usa molti ideogrammi. Ma quando ripete quattro volte l’espressione «fazzoletti di carta» in una pagina, quando descrive maniacalmente i gesti che un personaggio compie nel lavarsi e nel vestirsi, o fa una dettagliata lista della spesa, confesso sinceramente che qualche improperio glielo lancio. Ma perché non taglia, mi chiedo spesso, perché non stringe? Tanto più che a tradurre si impiega molto più tempo che a leggere e certe pagine mi sembrano interminabili. Poi, quando rileggo quello che ho scritto, mi rendo conto che invece ha ragione lui: perché nella vita succede proprio così, la gente dice e poi ridice sempre le stesse cose, ripete gli stessi gesti, cede alle proprie manie, e il fatto di rappresentare la realtà senza abbellirla è quello che rende i personaggi di Murakami così vicini al lettore, così umani e veri, le sue atmosfere così familiari e intime.
Antonietta Pastore, Perché non taglia, perché non stringe?, in «L’indice dei libri del mese», 7/8, XXX, luglio/agosto 2013, p. 40.
Filed under: tradurre, traduzione | Leave a Comment
Tag:Antonietta Pastore, Murakami
Bret Easton Ellis
Stile e social media
I social media hanno influenzato il tuo stile?
«Un tempo mi dilungavo, oggi sono molto più conciso. Ma più che il mio modo di scrivere, Twitter e Facebook hanno modificato quello di leggere, abbassando drasticamente la mia capacità di concentrazione: se ieri potevo divorare cento pagine di un romanzo in una sera, adesso fatico ad arrivare a venti. E sono anche più esigente per quanto riguarda la forma di ciò che leggo. Di un libro non mi interessa più la trama, mi concentro sulla prosa, che deve essere intensa ed essenziale, come la poesia».
Odio i conformisti del web, intervista di Paola Casella, «La lettura», n. 95, p. 7 (supplemento a «Corriere della sera», 13 settembre 2013).
Filed under: letteratura | Leave a Comment
Tag:Bret Easton Ellis, leggere, scrivere, social media, stile
Mercè Rodoreda
Fiori al Polo Nord
«Dopo la guerra impiegai molto tempo a ritornare a scrivere. Facevo già troppa fatica a sopravvivere. E scrivere in catalano all’estero è come voler far crescere fiori al Polo Nord».
«Después de la guerra tardé mucho en volver a escribir. Damasiado trabajo tenía para sobrevivir. Y escribir catalán en el estranjero es lo mismo que querer que florezcan flores en el Polo Norte».
Monteserrat Roig, El aliento poético de Mercè Rodoreda, intervista a M. Rodoreda, «Triunfo», XXVIII, 36, 20 settembre 1973, p. 37. Traduzione mia.
Mercè Rodoreda (si pronuncia ‘rudureda’), nata a Barcellona nel 1908, e impegnata durante la Guerra Civile nei servizi di propaganda repubblicani, visse in esilio dal 1939 al 1972, dapprima in Francia e poi in Svizzera. La sua opera, che la colloca tra le migliori scrittrici del Novecento, non solo spagnolo ma internazionale, è scritta interamente in catalano.
Filed under: bilinguismo, letteratura, scrivere | 1 Comment
Tag:bilinguismo, catalano, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, scrittori bilingui, scrivere all'estero
Italo Svevo
Le prove di Carla
Avevo esitato tanto perché era evidente che, anche senza maestro, Carla aveva saputo avviarsi ad un lavoro veramente serio nella sua nuova arte. Ogni settimana essa sapeva darmi una canzonetta nuova, analizzata accuratamente nell’atteggiamento e nella parola. Certe note avrebbero abbisognato di essere levigate un poco, ma forse avrebbero finito per l’affinarsi da sé. Una prova decisiva che Carla era una vera artista, io l’avevo nel modo come essa perfezionava continuamente le sue canzonette senza mai rinunziare alle cose migliori ch’essa aveva saputo far sue di prim’acchito. La indussi spesso a ridirmi il suo primo lavoro e vi trovavo aggiunto ogni volta qualche accento nuovo ed efficace. Data la sua ignoranza, era meraviglioso che nel suo grande sforzo di scoprire una forte espressione, non le fosse mai capitato di cacciare nella canzonetta dei suoni falsi o esagerati. Da vera artista, essa aggiungeva ogni giorno una pietruccia al piccolo edificio, e tutto il resto restava intatto. Non la canzonetta era stereotipata, ma il sentimento che la dettava. Carla, prima di cantare, si passava sempre la mano sulla faccia e dietro quella mano si creava un istante di raccoglimento che bastava a piombarla nella commediola ch’essa doveva costruire. Una commediola non sempre puerile.
La coscienza di Zeno, Dall’Oglio, Milano, 1938, p. 270.
Filed under: letteratura | Leave a Comment
Tag:comporre, correggere, interpretare, Italo Svevo, La coscienza di Zeno
Jorge Luis Borges
Dante in tram
Tutto cominciò poco prima della dittatura. Lavoravo in una biblioteca di Almagro. Abitavo in Avenida las Heras, angolo Pueyrredón, dovevo percorrere su lenti tram solitari il lungo tratto da quel quartiere del Nord fino ad Almagro Sud, per raggiungere una biblioteca sita in Avenida La Plata all’altezza di Carlos Calvo. Il caso (a meno che non esista, il caso, a meno che quello che noi chiamiamo caso non sia che la nostra ignoranza circa il complesso meccanismo delle probabilità) mi fece trovare tre piccoli volumi alla Librería Mitchell, oggi scomparsa, che mi fa tornare alla mente tanti ricordi. Quei volumetti (avrei dovuto portarne uno qui con me come talismano) erano le tre cantiche dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso tradotte in inglese da Carlyle, non Thomas Carlyle, del quale parlerò dopo. Erano libri molto comodi, dell’editore Dent. Mi entravano in tasca. Su una pagina c’era il testo italiano e sull’altra il testo in inglese, in traduzione letterale. Immaginai questo modus operandi: prima leggevo un versetto, una terzina, in prosa inglese; poi leggevo lo stesso versetto, la stessa terzina, in italiano; continuavo così fino alla fine del canto. Poi leggevo tutto il canto in inglese e poi in italiano. In quella prima lettura capii che le traduzioni non possono essere un succedaneo del testo originale. La traduzione può essere, semmai, un mezzo e uno stimolo per avvicinare il lettore all’originale; soprattutto nel caso dello spagnolo. Credo che Cervantes, da qualche parte nel Don Chisciotte, dica che con due grammi di lingua toscana uno può capire l’Ariosto.
Ebbene; quei due grammi di lingua toscana mi erano forniti dalla somiglianza fraterna tra l’italiano e lo spagnolo. Già allora osservai che i versi, soprattutto i grandi versi di Dante, sono molto più di quel che significano. Il verso è, tra le tante altre cose, un’intonazione, un’accentuazione il più delle volte intraducibile. Questo lo osservai fin dal principio. Quando arrivai al culmine del Paradiso, quando arrivai al Paradiso deserto, proprio lì, nel momento in cui Dante, abbandonato da Virgilio, si ritrova solo e lo chiama, in quel momento sentii che riuscivo a leggere direttamente il testo italiano e dare un’occhiata al testo inglese solo di tanto in tanto. Lessi così tutti e tre i volumi in quei lenti viaggi in tram. Poi ne lessi altre edizioni.
[Traduzione mia]
Todo empezó poco antes de la dictadura. Yo estaba empleado en una biblioteca del barrio de Almagro. Vivía en Las Heras y Pueyrredón, tenía que recorrer en lentos y solitarios tranvías el largo trecho que desde ese barrio del Norte va hasta Almagro Sur, a una biblioteca situada en la Avenida La Plata y Carlos Calvo. El azar (salvo que no hay azar, salvo que lo que llamamos azar es nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad) me hizo encontrar tres pequeños volúmenes en la Librería Mitchell, hoy desaparecida, que me trae tantos recuerdos. Esos tres volúmenes (yo debería haber traído uno como talismán, ahora) eran los tomos del Infierno, del Purgatorio y del Paraíso, vertidos al inglés por Carlyle, no por Thomas Carlyle, del que hablaré luego. Eran libros muy cómodos, editados por Dent. Cabían en mi bolsillo. En una página estaba el texto italiano y en la otra el texto en inglés, vertido literalmente. Imaginé este modus operandi: leía primero un versículo, un terceto, en prosa inglesa; luego leía el mismo versículo, el mismo terceto, en italiano; iba siguiendo así hasta llegar al fin del canto. Luego leía todo el canto en inglés y luego en italiano. En esa primera lectura comprendí que las traducciones no pueden ser un sucedáneo del texto original. La traducción puede ser, en todo caso, un medio y un estímulo para acercar al lector al original; sobre todo, en el caso del español. Creo que Cervantes, en alguna parte del Quijote, dice que con dos ochavos de lengua toscana uno puede entender a Ariosto.
Pues bien; esos dos ochavos de lengua toscana me fueron dados por la semejanza fraterna del italiano y el español. Ya entonces observé que los versos, sobre todo los grandes versos de Dante, son mucho más de lo que significan. El verso es, entre tantas otras cosas, una entonación, una acentuación muchas veces intraducibie. Eso lo observé desde el principio. Cuando llegué a la cumbre del Paraíso, cuando llegué al Paraíso desierto, ahí, en aquel momento en que Dante está abandonado por Virgilio y se encuentra solo y lo llama, en aquel momento sentí que podía leer directamente el texto italiano y sólo mirar de vez en cuando el texto inglés. Leí así los tres volúmenes en esos lentos viajes de tranvía. Después leí otras ediciones.
Jorge Luis Borges, <La Divina Comedia> (conferenza tenuta al Teatro Coliseo di Buenos Aires il 1° giugno 1977), in Siete noches, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1980.
Filed under: letteratura | Leave a Comment
Tag:Arthur Carlyle, Cervantes, Dante Alighieri, Divina Commedia, imparare le lingue, Jorge Luis Borges, tradurre la poesia, traduzione, traduzione a fronte, traduzioni
Roberto Calasso
Il revisore unico
Ma è il caso di ricordare anche un altro punto, che il pubblico non poteva che ignorare — e ha un sapore intensamente editoriale. Se la prosa, il fraseggio di Joseph Roth sono entrati così facilmente nelle vene della lingua italiana è anche per merito non tanto di qualcuno dei suoi numerosi traduttori, ma del suo revisore unico; Luciano Foà. Libro per libro, dalla Cripta dei Cappuccini (1974) fino a I cento giorni (1994), Foà si riservava ogni anno un certo numero di settimane in cui rivedeva Roth. Sembrava un suo compito ovvio e inalienabile. E il risultato era quella precisione nel dettaglio e quella patina delicata che proteggeva l’insieme, senza le quali non si può cogliere la peculiarità di Roth. Foà amava pochi scrittori senza riserve. Primi fra tutti, Stendhal e Kafka. E in Roth riconosceva la massima approssimazione a Stendhal che il Novecento aveva raggiunto.
Roberto Calasso, L’impronta dell’editore, Adelphi, Milano, 2013, pp. 31-32.
[I corsivi sono nell’originale.]
Filed under: letteratura | Leave a Comment
Tag:editing, Joseph Roth, Luciano Foà, revisore, rivedere un testo, Roberto Calasso, Stendhal, traduzione
Giorgio Vasta
Andarsene via
«Noi conosciamo il piacere del linguaggio, dice. Non soltanto il congiuntivo: il piacere delle frasi.
Mentre Bocca parla tocco il filo spinato, vivo, nella tasca del giubbotto.
Parlare in italiano, dice Scarmiglia, parlare complesso, per noi vuol dire andarcene.
Mi torna in mente la maestra che quasi un anno fa, durante gli esami, ironica e realistica mi aveva detto che sono mitopoietico, quanto ero stato contento di scoprire che cosa voleva dire, quale piacere può dare muoversi dentro le parole, passare il tempo nel linguaggio. Andarsene via costruendo frasi. Isolarsi. Perché la conseguenza del nostro modo di esprimerci — il tono sommesso, il volume basso, ogni parola piatta, ritagliata, calma eppure sediziosa — è che i nostri compagni di classe non ci riconoscono. Per loro siamo delle anomalie. Degli idioti. Quando poi sentono di che cosa stiamo parlando — le larghe analisi del presente politico italiano, la critica spregiudicata del potere — ci fanno le battute, ci lasciano soli.
Ce ne andiamo via da Palermo, continua Scarmiglia, semplicemente parlando.
Siamo colpevoli di linguaggio, esclama Bocca.»
Il tempo materiale, Minimum Fax, Roma, 2008, 2012, p. 56.
Filed under: letteratura | Leave a Comment
Tag:dialetto, Giorgio Vasta, lingua italiana, linguaggio, piacere del linguaggio, scrittori